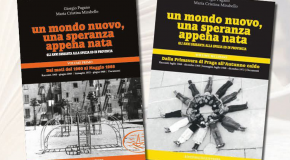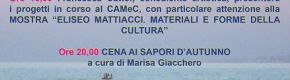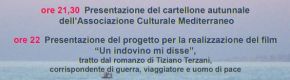Presentazione del libro “Storie di madri” di Susanna Baldi, La Spezia, Piazza Brin 16 aprile 2024 – Intervento di Giorgio Pagano
Presentazione del libro “Storie di madri”
di Susanna Baldi
La Spezia 16 aprile 2024,
Intervento di Giorgio Pagano
Il libro contiene tre racconti.
Ne consiglio la lettura per tre motivi:
la sapienza e la vitalità della scrittura, mai enfatica; quindi il valore letterario;
l’indagine dell’animo umano, di quello che della madre resta: nella vita, nella morte, nell’assenza (l’autrice è psicoterapeuta);
la spinta etica umanistica che sorregge le storie: “amore” è la parola chiave del libro.
La via del Mandorlo
Al centro c’è la perdita della madre, dell’amore, per un tumore.
E’ un racconto sulla vita e sulla morte.
Sulla riscoperta di un rapporto. E’ stata anche una mia esperienza personale. L’amore profondo è anche conflittuale.
Sono molto belle anche le pagine sulla natura. Soprattutto le pagine finali sulla comunione della natura che avviene in montagna: nella montagna vedo e sento ciò che resta, ciò che dura, sia della natura che dell’umano.
Profumo di madre
L’autrice rielabora un’esperienza vissuta in un orfanotrofio rumeno nella veste di operatrice umanitaria-psicologa.
Scrive Susanna:
“E’ rimasto incompiuto per anni perché il finale su cui lo avevo costruito riguardava una scena vista e vissuta da me in quell’istituto rimasta nella mia mente come una fotografia e che temevo non avrei saputo rendere ed onorare abbastanza con le parole. Poi il desiderio di partecipare a questo importante evento letterario ha reso possibile concluderlo e sciogliere definitivamente quell’impasse. L’ho scritto per elaborare il profondo dolore che ha accompagnato quell’esperienza di lutto”.
Qui c’è l’assenza della madre, dell’amore. Come fa un bambino a vivere senza la madre, senza l’amore?
Il racconto ci conduce nella tragedia della guerra. Degli orfani di Gaza e di tutte le guerre in corso.
Viviamo in una situazione di fervore bellico delle classi dirigenti e dei principali mass media, nonostante che la stragrande maggioranza dei cittadini non lo condivida. La politica è sempre più in crisi e sostituita dalla guerra: anche per questo i cittadini ne sono molto lontani. Secondo la studiosa del pensiero politico Catherine Ross “le guerre oggi stanno distruggendo ogni pensiero politico, la possibilità stessa di sviluppare un pensiero politico”. La politica buona è ricerca della pace, dell’accordo, della solidarietà, dell’amore.
La politica è entrata drasticamente in crisi quando queste parole sono state messe in archivio.
Gli occhi nelle lacrime
Il racconto è ispirato all’incontro che l’autrice ha avuto con Leonarda Papa (Lea) sopravvissuta ancora bambina alla strage nazifascista di Vinca.
Lea con tre bambini per tre giorni dentro un rifugio in un castagno .
Poi l’urlo “Sono andati tutti via, uscite tutti fuori!”
Lungo la strada Lea incontra la mamma uccisa.
Lea racconta la sua disperazione.
Vinca fu sterminata: 143 morti, nella stragrande maggioranza donne, anziani e bambini.
Perché Vinca? Non era una sede di brigata. Non c’è una spiegazione razionale.
Nella memoria della comunità la responsabilità ha un nome: Giovanni Bragazzi, sergente della Brigata Nera di Carrara, che aveva sposato una donna di Vinca e da lei si era separato, con molti contrasti. Una sorta di vendetta privata. Undici fascisti carrarini furono condannati all’ergastolo nel 1950, le pene furono ridotte nel 1952. Al resto pensò l’amnistia: Bragazzi fece solo cinque anni di carcere.
La massima responsabilità fu dei nazisti. Ma ci fu anche quella del fascismo della RSI, un fascismo “nazificato”.
Walter Reder fu arrestato nel 1948 in Baviera dagli americani ed estradato in Italia, dove venne processato a Bologna per le stragi di San Terenzo e di Vinca e poi di Sant’Anna di Stazzema e di Marzabotto e condannato all’ergastolo. Scarcerato nel 1985 per volontà del governo Craxi, rientrò in Austria accolto come un eroe. Nel 1986 dichiarò a un settimanale: “Non ho bisogno di giustificarmi di niente!”.
Negli atti processuali contro Reder si legge, riguardo a Vinca:
“Il cadavere di una povera vecchia mendicante è stato ritrovato con un palo conficcato nel didietro. Un’altra donna che era in stato di gravidanza assai avanzato, dopo essere stata uccisa fu sventrata ed il feto schiacciato con i piedi. Un’altra donna è stata ritrovata con un palo conficcato nei genitali. A Vinca i bimbi in fascia venivano lanciati in aria e poi fatti segno con arma da fuoco”.
Fu una crudeltà scientifica. Un progetto eliminazionista.
Il racconto ci fa vivere il dramma dalla parte dei sopravvissuti: una bambina senza madre, senza amore, che ha visto gli orrori del progetto eliminazionista. Furono esperienze estreme, al limite della possibilità umana di rielaborarle.
E’ un mondo dove ci sono le vittime e i carnefici, il bene e il male, l’amore e l’odio, la pace e la guerra: allora come oggi.
Riemergono dal fondo della storia forze brutali e imprevedibili delle quali si era quasi persa memoria.
Tuttavia: aveva ragione Vittorio Foa a sostenere che il Novecento non va letto come “un’ininterrotta violenza distruttiva”, perché esso è anche “frutto di passioni e di sofferenze, di invenzioni individuali e collettive, di interi cicli di lotte sociali”.
ll Novecento non è stato solo violenza e politica come potenza. È stato anche altro, infinite possibilità positive. Fratellanza, solidarietà, mutualismo, internazionalismo, amore.
Parole dell’altro Novecento. La Resistenza ne fu il momento più alto. Poi gli anni Sessanta e il Sessantotto continuarono in forme nuove la lotta etica umanistica.
“Amore” è la parola al centro di Lettere dei condannati a morte della Resistenza.
Bella ciao nasce come canzone d’amore, secondo Giovanna Marini. Lui deve andare, lei, se lui morirà per l’amore, per la vita, coltiverà il fiore, il corpo, l’amore. Bella ciao è un canto di ribellione, di lotta, di resistenza, ma non è un canto militare. Non dice guerra, ma amore, coraggio, dono di sé, vita nuova, dono di civiltà. Bella ciao canta la resistenza umana, sia di lui che di lei, forte, più forte delle armi.
Poi vennero gli anni Sessanta e il Sessantotto.
“Amore” è in We shall overcome, è in La ballata di Sacco e Vanzetti di Joan Baez…
Poi amore e politica si separeranno sempre più.
Quei movimenti etico umanistici erano anche amore e ricerca di un nuovo modo di vivere.
Da lì possiamo ripartire per costruire una storia nuova.
Popularity: 5%