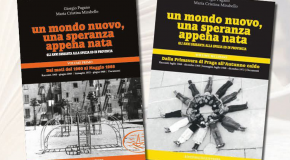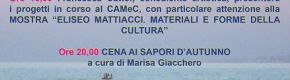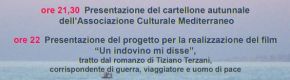Le vie della Resistenza a Sarzana. Ragioni della loro attualità – Sarzana, 18 Aprile 2024 – Intervento di Giorgio Pagano
Le vie della Resistenza a Sarzana. Ragioni della loro attualità
18 aprile 2024, Sarzana – Circolo Pd Grisei
Intervento di Giorgio Pagano
co presidente del Comitato Unitario della Resistenza
Le vie sono in grado di far rivivere le persone. Sono un riconoscimento ai Martiri della libertà. Avrei detto questa frase anche se a Sarzana non ci fosse stata piazza Martiri della Libertà. E piazza Libertà, viale 25 aprile, via Brigate partigiane, via Brigata partigiana Muccini – che fu la brigata dei sarzanesi, o meglio della Val di Magra, anche se non mancarono gli operai lericini e spezzini, in particolare migliarinesi.
L’azione tesa a intitolare le vie della Resistenza deve coniugare due aspetti cruciali e convergenti: da un lato la necessità di essere saldamente ancorati allo studio della Resistenza, alle biografie dei suoi protagonisti, agli eventi più significativi; dall’altro, la volontà di portare avanti la visione della Resistenza.
Nel libro “La collina rossa” di Riccardo Vinciguerra, ambientato in Lunigiana, Enio dice a Riccardo:
“A volte penso se vale proprio la pena di fare tutti questi sacrifici, poi morire e rimanere dimenticati per sempre da tutti e forse seppelliti in qualche angolo degli appennini senza nome e senza una croce che ci circondi”.
Sta a noi far sì che il ricordo sia durevole, che i partigiani non restino dimenticati. A loro dobbiamo la libertà, e il bene più prezioso che abbiamo: la Costituzione.
La Brigata “Muccini” prende il nome da un comunista arcolano morto eroicamente combattendo nella guerra di Spagna, e si costituisce formalmente a fine estate 1944. Ma la sua storia comincia prima, con le formazioni che la precedettero. Si suol dire che la “Muccini” fu essenzialmente emanazione della sezione sarzanese del Pci, con una fisionomia decisamente politica e classista. In ciò c’è un po’ di “autorappresentazione”, ma fondamentalmente fu così: l’espressione, come scrisse Giulivo Ricci nella sua “Storia della Brigata garibaldina Ugo Muccini”, “di un gruppo abbastanza omogeneo… unico nell’intera provincia della Spezia, ove altri gruppi esistettero, affondanti le radici negli anni del ventennio, ma meno forti, meno omogenei, meno dotati di coesione e di coerenza nell’azione, e perciò più esposti ai pericoli della divisione, dell’incertezza, della mancanza di direzione unitaria”.
Leggiamo ancora Ricci:
“Non esisteva iattanza od ostentato senso di superiorità; certo, non difettava in molti la coscienza, non già di essere migliori, ma di essere stati posti in grado, dalle circostanze e dalla volontà, di conseguire una capacità di valutazione degli avvenimenti e un’organizzazione quali non sempre e non subito altri seppero promuovere”.
Non a caso decine e decine di “quadri” usciti dalle file della “Muccini” si affermarono negli organismi democratici, istituzionali e sociali, della Val di Magra e della provincia, e anche nel Parlamento e nel Pci nazionale. Ricci mise in evidenza il contributo alla “Muccini” e alla Resistenza in generale anche dei partigiani di Arcola e degli altri Comuni della Val di Magra, Santo Stefano soprattutto, il cui apporto non fu secondo a nessuno in termini quantitativi, anche se con “le manchevolezze e i punti deboli” dell’individualismo ribellistico e protestatario dell’”incolto proletariato rurale e operaio santostefanese”, di cui era tipica espressione Primo Battistini ‘Tullio’, uno dei capi della “Muccini”. Il suo antifascismo, scrisse Ricci, “era istintivo, alieno da ogni preoccupazione politica e partitica, venato di sentimenti anarchici e piuttosto insofferente ai freni” che i comunisti sarzanesi “avrebbero voluto a buon diritto imporre”.
Una figura, quella di “Tullio”, su cui ho scritto e su cui tornerò, curando la pubblicazione delle sue memorie. Compì azioni eroiche ma commise anche molti errori, che pagò. E’ una figura su cui fare più luce. Il giudizio di Ricci va meglio articolato.
I primi gruppi a salire ai monti nello Spezzino furono due, nei giorni immediatamente successivi all’8 settembre. Sul Monte Grosso, tra Santo Stefano Magra e Caprigliola, salì il gruppo di Primo Battistini. L’altro gruppo era quello degli antifascisti sarzanesi, comunisti soprattutto: il nucleo della futura Brigata “Muccini”. Recuperarono le armi ammucchiate dai tedeschi, per poi salire ai monti. Giorgio Bocca chiamò il gruppo sarzanese “il gruppo di Monte Nebbione”, la collina più alta (appena 691 metri) della zona, nella Lunigiana Toscana (Fosdinovo). Erano poco più di una ventina. C’erano, tra gli altri, Arturo Emilio Bacinelli, responsabile organizzativo e militare, Paolino Ranieri “Andrea”, informalmente “commissario politico”, Alfio e Vittorio Forcieri, Turiddo Perugi, Guglielmo Vesco, Goliardo Luciani, Ugo Boccardi vulgo “Ramella” (anarchico). I punti di riferimento principali del gruppo, oltre a Bacinelli e a Ranieri, erano Dario Montarese “Briché” e soprattutto Anelito Barontini. La banda, così come quella di Battistini, raggruppò alcuni alpini sbandati.
Bacinelli fu richiamato a Sarzana nel gennaio 1944 per compiere azioni gappistiche. Ma già dal novembre 1943 i gruppi sulle colline della Val di Magra si attivarono per compiere attentati a Sarzana ai fascisti più in vista.
A fine dicembre i due gruppi si unirono e si spostarono al Trambacco, una località in mezzo ai boschi nel territorio del Comune di Tresana (MS), per sfuggire a un rastrellamento nelle colline dei Cappuccini a Sarzana. Le località più in basso erano diventate troppo pericolose. Fu il primo rastrellamento effettuato contro la Resistenza delle nostre zone.
Sarzana fu anche il luogo del primo attentato gappistico vero e proprio, la sera del 13 dicembre 1943, contro i fascisti. Il maggiore Rago, commissario prefettizio di Sarzana e segretario del Fascio locale, fu oggetto di colpi di pistola. Nei giorni precedenti erano falliti due attentati contro di lui. Rago e il segretario comunale che lo accompagnava, Eugenio Gari, rimasero feriti, il secondo in modo più grave. Gli attentatori appartenevano alla squadra gappista costituita da Bacinelli: un reparto particolarmente efficiente, costituito in stretta collaborazione con i comunisti sarzanesi saliti ai monti e con lo stesso Battistini.
La reazione fascista fu furiosa. Il giorno dopo l’attentato a Rago il Ministero dell’Interno scrisse alla Direzione nazionale della Polizia: si era proceduto a quaranta arresti e al coprifuoco fino alle 19. Gli arresti salirono a un centinaio, ma la rappresaglia fu poi mitigata dal prefetto Franz Turchi.
Mi sono soffermato di più sulle vicende iniziali, anche perché meno note. E poi perché in questo modo conosciamo il nucleo originario della Muccini, quello che merita una valorizzazione particolare.
La storia successiva è più nota.
Un gruppo di sarzanesi e di arcolani, con “Tullio”, si recarono a Valmozzola, nel parmense, a rafforzare la “Banda Betti”, formazione guidata da Mario Betti. Il 12 marzo del 1944 fu il giorno dell’attacco al treno di Valmozzola, con la morte di Betti e il successivo massacro dei partigiani sul monte Barca. “Tullio” subentrò nel comando a Betti, ma dopo qualche tempo venne messo in minoranza a causa dei suoi metodi di conduzione. Nacque il distaccamento “Mario Betti”, con il reggiano Ezio Saccani “Renzo”, che era stato con i fratelli Cervi, comandante, e lo spezzino Mario Portonato “Claudio” commissario politico. Poi gli spezzini si ricongiunsero, sempre con “Tullio” comandante.
Ranieri e altri si erano spostati nel parmense, a Bardi, insieme agli uomini fino ad allora rimasti con Vesco e Flavio Bertone “Walter”, un giovane operaio sarzanese che si era contraddistinto per coraggio e audacia, a Vallecchia. Qui si ripropose la questione di “Tullio”, che si convinse di dover abbandonare il comando e la zona, e si spostò nello Zerasco, dando vita al raggruppamento “Signanini”, poi, da fine luglio 1944, Brigata “Vanni”. Il comando fu assunto da “Walter”, con “Andrea” commissario politico. Il gruppo, unito alla XII Brigata Garibaldi “Parma”, fu protagonista della costituzione della “zona libera” del Ceno, una tra le prime, se non la prima, in Italia (10 giugno 1944): gli spezzini eseguirono la parte forse più importante dell’azione, la liberazione di Bardi. Intanto nasceva anche la “zona libera” del Taro, grazie anche alla nostra Brigata “Centocroci”. Ma, nei giorni successivi, i nazifascisti passarono all’offensiva: prima il libero Stato partigiano del Taro, poi quello del Ceno furono sconfitti. Il 15 luglio iniziò lo sganciamento dei partigiani da Bardi. Il rastrellamento nella valle sarebbe durato fino al 29 luglio.
Dopo l’arrivo a Roma degli alleati, il Comitato di Liberazione Nazionale (C.L.N) della Spezia chiese, verso il 10 luglio, che il gruppo di Bertone e di Ranieri rientrasse nella zona di Sarzana, alla Nuda di Falcinello. Qui arrivò, dopo varie vicissitudini, ai primi di agosto, un altro gruppo di partigiani, comandato da Piero Galantini “Federico”, anche lui sarzanese, democratico non ancora comunista, proveniente da una vecchia famiglia antifascista. “Federico” era stato probabilmente il comandante della Brigata “37B”, dissolta da un grande rastrellamento: dalle sue radici nacque la Brigata garibaldina “Leone Borrini”. Membro della “37 B” e poi comandante della “Borrini” fu Edoardo Bassignani “Ebio”, di Merizzo, comunista e libertario, ucciso nel cuore del paese, alla presenza della madre, il 3 febbraio 1945. Con la fine di luglio 1944 aumentò nella bassa Val di Magra l’affluenza di partigiani: si pose la questione dell’unità dei tanti distaccamenti. Nacque così, il 19 settembre 1944 nel bosco di Faeta sopra Falcinello, la Brigata “Muccini”, con “Federico” comandante, “Walter “ vice e Dario Montarese “Brichè” commissario. “Andrea” divenne Ispettore per il Pci delle brigate garibaldine.
Con il parere contrario del comandante della Divisione Mario Fontana e del C.L.N “Tullio” rientrò nella “Muccini”, dopo che era stato estromesso dal comando della “Vanni”. Aveva con sé 200 uomini, perché “Tullio” continuava ad avere un grande fascino sui giovani, che si dichiaravano quasi tutti comunisti. Ranieri era però contrario al reinserimento di “Tullio” come comandante di uno dei distaccamenti della “Muccini”. Esso avvenne per volontà di Pietro Perpiglia, dirigente del Pci (che per questo fu censurato nel dopoguerra). “Tullio” esprimeva un’anima del partigianato, esplosiva, ribelle, protestataria. Era questa la sua forza. Anche la sua debolezza politica, certo. Ma le due anime dovevano convivere. E’ qui che correggerei il giudizio di Ricci, che ho riportato all’inizio. Il maggior senso politico dei dirigenti comunisti sarzanesi (non parliamo dei dirigenti comunisti ai monti in Val di Vara e nello Zerasco, tutta un’altra risma) non era sufficiente di per sé, aveva bisogno anche dell’altra anima. Si doveva andare verso l’esercito partigiano, ma democratico, senza le tradizionali gerarchie, con il rispetto dell’autonomia delle formazioni. Era questo l’incontro da fare, la sintesi da cercare.
Va aggiunto che a Faeta aderì alla “Muccini” anche il gruppo di Lindo Galletto “Orti”, di sinistra ma senza un vero legame con il Partito Comunista: un’autonomia ideologica e anche organizzativa, che rimase una caratteristica costante del gruppo.
Il comando di brigata si insediò a Canepari, nella scuola. L’unità delle bande della Val di Magra era un fatto positivo ed esaltante. Le azioni furono frequenti, importanti e a volte clamorose.
Il 24 settembre 1944 una pattuglia del distaccamento “Signanini”, composto da uomini di “Tullio”, uccise un tedesco a Ressora di Arcola, mentre altri due vennero fatti prigionieri. Dieci giovani vennero fucilati da tedeschi e fascisti per rappresaglia.
Il 3 novembre il capitano tedesco Rudolf Jacobs, che aveva disertato e aderito alla ”Muccini”, organizzò un eroico e sfortunato attacco contro la caserma delle brigate nere sita nell’albergo “Laurina”: Jacobs cadde crivellato di colpi.
Il 28 novembre, durante un attacco ai tedeschi in Garfagnana, condotto dalla “Muccini” assieme alla Divisione “Lunense” e agli Alleati, che però all’ultimo momento rinunciarono a intervenire, morì eroicamente Miro Luperi “Reno”, per proteggere la ritirata dei compagni.
Ma la “Muccini” aveva un punto di debolezza: la ristrettezza del territorio, la sua accessibilità da ogni lato. La brigata non era in montagna, ma in colline esposte alle facili avventure dei nazifascisti. Questo punto di debolezza, purtroppo, venne alla luce durante il grande rastrellamento del 29 novembre 1944.
Il grosso della brigata si diresse, sotto la guida di Galantini, verso le Alpi Apuane per passare le linee e giungere nelle zone già in mano agli Alleati. La decisione suscitò la critica del Partito comunista. “Federico” passò le linee con l’intenzione di chiedere armi e ritornare in zona, ma trovò il diniego degli Alleati. Solo il 5 aprile 1945 ottenne di essere impegnato con i suoi uomini: si creò la così detta Brigata “Muccini di linea”, che partecipò alla fase finale della lotta. Bertone e Ranieri rimasero invece nascosti nei boschi della zona per occuparsi dei feriti. “Andrea” cadde in un’imboscata il 14 dicembre proprio mentre era in cerca di medicinali, fu ferito, arrestato e incarcerato al XXI Reggimento a Spezia, dove rimase prigioniero, nonostante i tanti tentativi di liberarlo, fino al 23 aprile 1945. “Walter” riuscì, il 16 dicembre, a ricostituire formalmente la “Muccini”, con sei distaccamenti. Con lui, eletto comandante, c’erano Dario Montarese “Brichè”, Mario Portonato “Claudio” e Goliardo Luciani “Wladimiro”.
La “Muccini” di “Walter”, pur numericamente esigua e senza aiuti da nessuno, fu comunque molto attiva. Il 2 aprile morì in combattimento la prima donna: Amanda Lidia Lalli “Kira”, figlia di un esponente socialista, che era entrata nella brigata, inizialmente, come infermiera.
“Walter” e i suoi uomini furono protagonisti della liberazione di Fosdinovo e di Sarzana, il 23 aprile, prima degli Alleati. La “Muccini” fu raggiunta dalla “Muccini di linea”: nella piazza di Sarzana ci fu l’abbraccio tra Bertone e Galantini, che sanzionava l’impegno comune degli antifascisti sarzanesi.
Un’ultima considerazione. Ranieri diceva sempre che i primi gruppi si erano formati in modo diverso: da un lato i politici, i “vecchi” antifascisti, dall’altro lato gli altri, i più giovani.
Resta innegabile, come scrisse lo storico Guido Quazza:
“il fatto che di contro all’’attendismo’ e di contro al collaborazionismo molti sono coloro i quali, senza essere quadri politici (per lo più comunisti e giellisti), imbracciano subito con risolutezza le armi e prendono la via della montagna per formare il secondo tipo, accanto a quello politico, di ‘banda’ partigiana, quello di volontari e ex militari. Ed essi sono in grande prevalenza giovani, il cui profilo politico rivela una maturazione all’antifascismo nata da ragioni morali o propriamente esistenziali”.
Per restare a Sarzana, accanto ai “vecchi” antifascisti, tra le prime a impegnarsi troviamo Anna Maria Vignolini, nata nel 1943. Partecipò alla manifestazione del 27 luglio e poi le fu affidato da Barontini e Ranieri il compito di organizzare le donne. Così ricorda quella che definisce “la svolta”:
“Anche noi ragazze ci davamo da fare, non parlavamo più di di ballo o di ragazzi. Andavamo in bicicletta al fiume in costume, per dare la sensazione di essere innocui bagnanti, invece facevamo riunioni politiche. Cantavamo ‘Bandiera rossa’ e l’’Internazionale’ sul greto del fiume o nel Campo dei Cappuccini, dove ora c’è lo stadio. Prima ero timida, riservata e un po’ paurosa, di svenimento facile, poi il lavoro clandestino mi diede coraggio. Gli ideali portano a osare cose inimmaginabili”.
La migliore risposta possibile ai tentativi di riscrittura della storia e dei valori della nostra comunità cui stiamo assistendo è proprio la storia. Non intesa come disciplina asettica, ma come processo di conoscenza in costante evoluzione, vivo e appassionato, incalzato dalle domande del presente.
Una storia che faccia emergere le soggettività, con la loro moralità e le loro contraddizioni. Le grandezze e le miserie di partigiani in carne e ossa. Come ci hanno insegnato i grandi storici, a partire da Claudio Pavone, e i testimoni-scrittori: Fenoglio, Calvino, Revelli, Meneghello… L’unico modo per mantenere in vita la Resistenza, il significato della lotta contro il fascismo, è fare opera di verità, guidati dalla passione e dal rigore. Non c’è una storia appiattita che porta all’apoteosi finale. C’è una storia tortuosa, tormentata. Anche nella Resistenza ci furono i vinti, e sono vinti che ci parlano ancora.
Sulla base di questa concezione della storia Sarzana può e deve sviluppare una nuova riflessione sul suo “Stradario”.
Matteo Del Vecchio ha relazionato sulle vie e sui luoghi sarzanesi già intitolati ai partigiani: Esperio Baruzzo (area verde), Eugenio Bellegoni (via), Socrate Benacci (via), Flavio Bertone (parco), Nilo Garbusi (via), Enzo Meneghini (piazza), Oriano Lucio Musso (area verde), Giuseppe Picedi Benettini (via), Pietro Arnaldo Terzi (via), Sildo Venturini (area verde), Carlo Zappa (piazza).
Si tratta di partigiani della “Muccini” Caduti, a parte i socialisti Terzi (già sindaco, deportato a Mauthausen e deceduto a Hartheim) e Zappa, e il conte Picedi Benettini, ucciso a Bosco di Corniglio, partigiano nel Parmense, dove operò insieme a Franco Franchini, cattolico e democristiano.
Franchini appare come una figura senz’altro da ricordare nel “nuovo Stradario”.
Così come il nucleo fondatore della “Muccini”: Ranieri e Luciani, che furono anche Sindaci, il primo per moltissimi anni; Barontini, a cui è intitolato comunque un centro sociale; Bacinelli, il gappista; Montarese “Brichè”, il commissario; ma anche Boccardi, l’anarchico, e la Vignolini.
Ancora: il comandante della “Muccini” da Faeta in poi, Galantini.
Alcuni Caduti hanno avuto altre intitolazioni: Luperi lo stadio, la Lalli una scuola, il democristiano Isio Mattazzoni, morto a Mauthausen, una scuola. Una scuola è intitolata anche ad Alfredo Poggi, socialista, sopravvissuto alla deportazione.
Andrebbe fatto uno studio organico su tutti i Caduti.
Inoltre andrebbe approfondito e ricordato il ruolo dei sarzanesi in Val Ceno.
Indubbiamente alcune “assenze” appaiono eclatanti, e ad esse occorre rimediare al più presto. Ma una riflessione organica è necessaria, per un lavoro da qui all’Ottantesimo e anche oltre.
Giorgio Pagano
co presidente del Comitato Unitario della Resistenza
Popularity: 1%